Il mito dell'elettore razionale
Il libro "Democracy for Realists" spiega come democrazia funzioni molto diversamente da quello che pensiamo.
L’idea alla base della democrazia prevede che i cittadini si informino, maturino preferenze coerenti, confrontino i programmi e scelgano chi li rappresenta meglio. Ma in realtà si tratta più che altro una favola che ci raccontiamo e non della realtà. Questa è la tesi di Christopher Achen e Larry Bartels, due political scientist, in Democracy for Realists, un libro che smonta pezzo per pezzo l’idea dell’elettore informato e razionale. Gli autori si concentrano principalmente sul contesto americano, ma le loro conclusioni hanno implicazioni per tutte le democrazie moderne, Italia compresa.
Partiamo da un dato scomodo: la stragrande maggioranza dei cittadini presta pochissima attenzione alla politica. Non tanto per pigrizia, ma semplicemente perché hanno impegno e priorità più immediate. Come scrivono gli autori, senza trascurare “obblighi più immediati e importanti, le persone non hanno molto tempo per dedicarsi a riflessioni politiche ben informate e ponderate”.
Questa realtà si scontra frontalmente con quella che Achen e Bartels chiamano la “teoria popolare della democrazia” (”folk theory of democracy”), l’idea che i cittadini determinino le politiche pubbliche attraverso scelte consapevoli e informate. La verità è che le elezioni sono determinate da forze potenti, ma queste forze non sono quelle che le teorie democratiche tradizionali credono dovrebbero determinare i risultati elettorali.
Se gli elettori non basano le proprie scelte su un’analisi razionale delle politiche proposte, cosa guida il voto? La risposta è semplice: l’identità di gruppo e le fedeltà partitiche, spesso acquisite nell’infanzia.
“La maggior parte dei cittadini sostiene un partito non perché ha calcolato attentamente che le sue posizioni politiche sono più vicine alle proprie”, spiegano gli autori, “ma piuttosto perché ‘il loro tipo’ di persona appartiene a quel partito”. Le fedeltà partitiche riflettono il modo in cui le persone vedono la propria vita: il lavoro, le visioni religiose, le identità ancestrali, le tradizioni familiari e i legami personali.
Questo fenomeno non è limitato agli Stati Uniti. Pensiamo all’Italia: quante volte abbiamo sentito frasi come “in famiglia siamo sempre stati di sinistra/destra”. Il voto diventa un atto di appartenenza sociale prima che una scelta razionale sui programmi.
Si potrebbe obiettare che molte persone sanno spiegare perfettamente perché votano un certo partito, elencando politiche e programmi. Achen e Bartels hanno una risposta anche per questo: quelle spiegazioni apparentemente razionali sono spesso razionalizzazioni a posteriori delle fedeltà di gruppo già esistenti.
I cittadini tendono ad adottare le posizioni dei partiti e dei gruppi che sostengono. Se sono particolarmente impegnati politicamente, possono persino sviluppare strutture ideologiche che razionalizzano le loro fedeltà di gruppo e denigrano quelle degli avversari. A volte costruiscono persino “fatti” convenienti per sostenere le loro fedeltà.
Paradossalmente, i cittadini più informati e attenti alla politica sono spesso più soggetti a pregiudizi di parte rispetto ai loro vicini meno attenti. La maggiore conoscenza serve principalmente a costruire razionalizzazioni più elaborate e internamente coerenti delle loro posizioni preesistenti.
Una teoria alternativa sostiene che gli elettori, anche se non seguono i dettagli delle politiche, almeno giudicano i governi in base ai risultati: se le cose vanno bene, riconfermano; se vanno male, cambiano. Questa teoria del “voto retrospettivo” sembra più realistica, ma Achen e Bartels dimostrano che anche questa non funziona come dovrebbe.
Il problema è che gli elettori hanno enormi difficoltà nel valutare se i tempi sono stati buoni o cattivi durante il mandato di un governo e ancora più difficoltà nell’attribuire correttamente le responsabilità. I governi vengono puniti “alla cieca” per i tempi difficili, inclusi quelli chiaramente dovuti a eventi fuori dal loro controllo.
Pensiamo alla pandemia di Covid-19 e al periodo inflazionistico: quanti governi nel mondo sono stati puniti elettoralmente per una cosa che nessuno avrebbe potuto prevedere o controllare completamente?
Si potrebbe pensare che almeno gli elettori “indipendenti” o centristi, quelli non legati a un partito, siano più razionali. Ma la ricerca mostra il contrario: questi elettori sono spesso meno informati e meno chiari su quali gruppi “appartengano” a quale partito. Non riuscendo a capire cosa sia in gioco nella scelta tra partiti diversi, sono spesso trascinati dalla familiarità di un candidato uscente, dal carisma di un nuovo sfidante o da un generico sentimento che sia “ora di cambiare”.
Il risultato? “Dal punto di vista della rappresentatività governativa e della responsabilità, i risultati elettorali sono essenzialmente scelte casuali tra i partiti disponibili, come nel gioco delle sedie”. Le elezioni non producono “genuini mandati politici”, ma semplicemente “mettono al comando una coalizione diversa”.
Se tutto questo è vero, cosa significa per il futuro della democrazia? Achen e Bartels non suggeriscono di abbandonare il sistema democratico, ma di ripensarlo con maggiore realismo.
Prima di tutto, dobbiamo riconoscere che l’alternanza al potere, anche se basata su fattori in gran parte casuali, è comunque un indicatore chiave della salute democratica. Impedisce che un gruppo o coalizione si radichi al potere e, poiché i perdenti di ogni elezione possono ragionevolmente aspettarsi che la ruota della fortuna politica giri in futuro, sono più propensi ad accettare il risultato piuttosto che scendere in piazza.
In secondo luogo, quando la politica è dominata da appartenenze di gruppo e alcuni gruppi hanno molto più potere economico e risorse di altri, questi gruppi privilegiati possono esercitare un’influenza sproporzionata sul processo politico. Possono finanziare campagne, controllare i media, organizzare lobby più efficaci. Per questo motivo, secondo Achen e Bartels, “una democrazia più efficace richiederebbe un maggior grado di uguaglianza economica e sociale”. In altre parole, se vogliamo che la competizione tra gruppi sia più equa e che la democrazia rappresenti davvero tutti i cittadini, non solo quelli con più risorse, dobbiamo prima ridurre le disuguaglianze economiche e sociali tra i diversi gruppi della società.
In conclusione
La democrazia non è, e probabilmente non sarà mai, il regno della razionalità politica immaginato dai teorici della democrazia. Gli elettori non sono esperti che soppesano attentamente pro e contro di ogni proposta politica. Sono persone che lavoro e con poco tempo da dedicare alla politica, con identità complesse e fedeltà radicate, che usano scorciatoie mentali per navigare in un mondo politico complicato.
Riconoscere questi limiti significa smettere di illuderci che bastino più informazione o più educazione civica per “aggiustare” la democrazia. Andrebbe invece ripensato il sistema. Se accettiamo che gli elettori non controllano davvero cosa fanno gli eletti dopo il voto, servono altri meccanismi di controllo durante il mandato. E soprattutto, accettare che la democrazia non produce governi perfetti o scelte ottimali, ma solo la possibilità di mandare facilmente a casa chi governa.


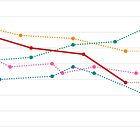
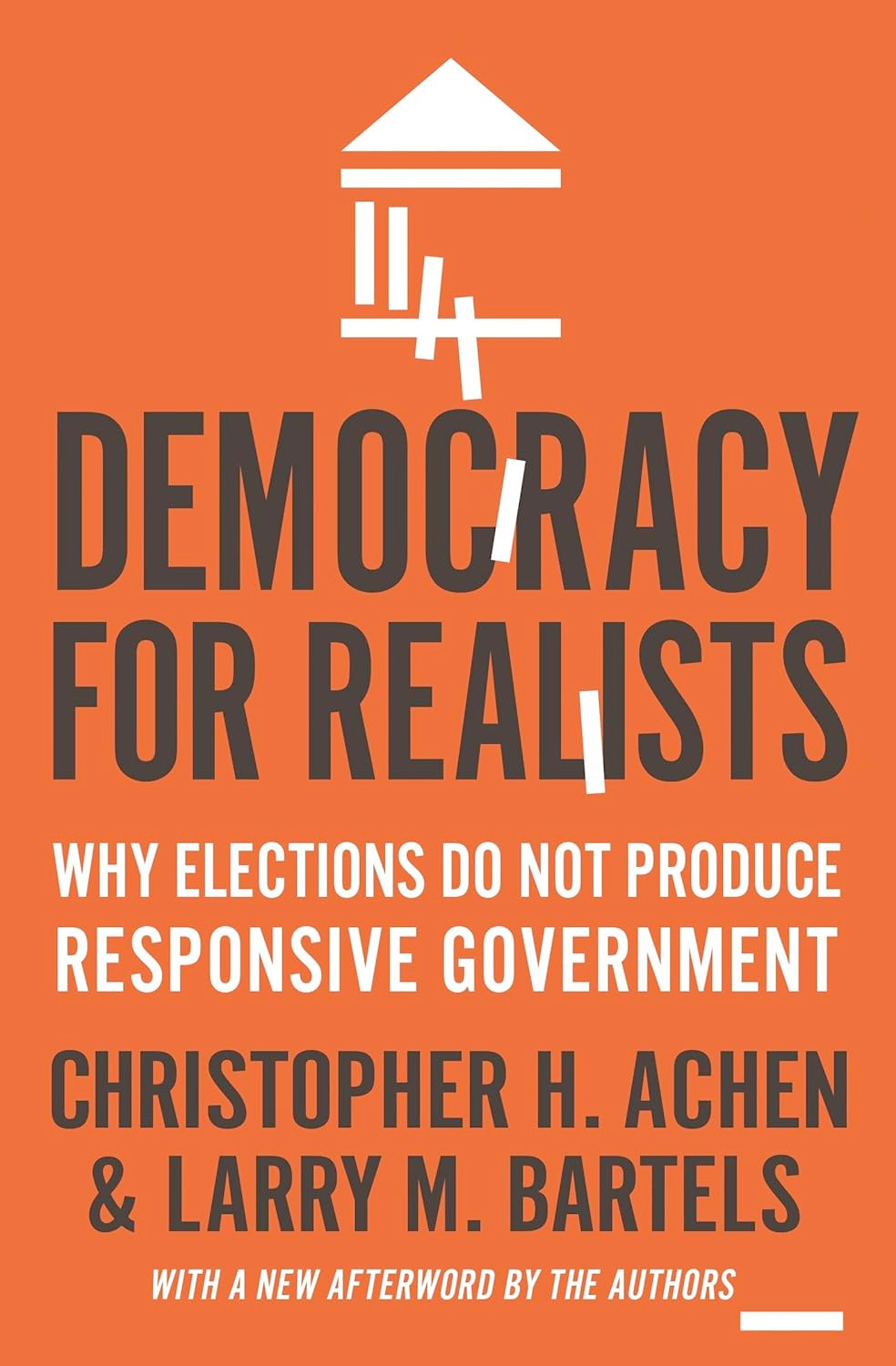
Non sono un politologo, né un giurista e nemmeno un sociologo. Ma di fronte alla crisi della partecipazione politica che avanza sempre di più (prova ne sia l'astensionismo crescente alle elezioni e, in generale, il disinteresse alla vita pubblica) mi chiedo se non sia il caso di ripensare l'idea stessa di democrazia. O quantomeno le sue regole e le sue istituzioni.
D'altronde, nel corso del tempo tutto cambia e oggi viviamo in società radicalmente diverse rispetto a qualche decennio fa. Solo per fare degli esempi: è cambiata la famiglia, è cambiata la scuola, è cambiato il sentimento religioso, è cambiato il lavoro, è cambiata la comunicazione (sia di massa che interpersonale), sono cambiati i rapporti sociali, è cambiato il modo in cui mangiamo, e via dicendo.
Perché dovremmo continuare a votare, o a fare le leggi, o a essere cittadini di uno Stato, come 50 anni fa? La mia è una riflessione forse provocatoria, ma credo che se cambia il demos, possa cambiare anche il sistema istituzionale che lo rappresenta e il modo in cui esercita il suo potere.