Perché gli stipendi in Italia sono bassi
Trent'anni di stagnazione: come l'Italia ha scelto di difendere l'esistente invece di innovare
Trent’anni senza crescita. Questo è ciò che mostrano i dati dell’OCSE sui redditi da lavoro in Italia: dal 1991 al 2023, a parità di potere d’acquisto, sono scesi del 3,4 per cento. Un’anomalia nel panorama delle economie avanzate, dove nello stesso periodo i salari sono cresciuti in media del 30 per cento. Come è potuto accadere? E soprattutto, perché solo in Italia?
La risposta non è semplice, né può essere ridotta a un unico colpevole. La stagnazione salariale italiana è il risultato di un intreccio complesso di fattori economici, strutturali e sociali che si sono accumulati nel tempo. Un processo che ha origine negli anni Novanta, quando l’Italia si è trovata a dover competere in un mondo radicalmente cambiato senza avere gli strumenti per farlo. È quanto emerge dall’analisi condotta dall’economista Andrea Garnero e dal giornalista Roberto Mania nel libro “La questione salariale” (Egea, 2025).
La bassa produtttività
La dinamica salariale è legata a quella della produttività. La produttività misura quanto valore viene prodotto per ogni ora di lavoro: più un’economia è efficiente nel produrre beni e servizi, più può permettersi di pagare i suoi lavoratori. Storicamente, quando la produttività cresce, crescono anche i salari. È una relazione che ha funzionato per decenni in tutte le economie avanzate: lavoratori più produttivi portano a aziende più competitive, che possono permettersi di pagare di più.
Qui emerge un dato che distingue l’Italia da tutti gli altri paesi OCSE: il blocco totale della crescita della produttività. Mentre negli altri paesi la produttività è cresciuta, anche se più lentamente che in passato, in Italia è rimasta sostanzialmente ferma per trent’anni. Un’anomalia che da sola spiega gran parte della questione salariale italiana. Senza crescita della produttività, semplicemente non ci sono le risorse economiche per aumentare in modo sostenibile le retribuzioni.
Dietro questa stagnazione ci sono scelte precise. Mentre altri paesi europei subivano anch’essi un processo di deindustrializzazione ma si orientavano verso lavori intellettuali di alto valore come la consulenza tecnica, quella finanziaria o il marketing, l’Italia ci è arrivata più tardi. Nella prima fase ha conosciuto invece un aumento significativo delle attività dedicate alla famiglia, il lavoro domestico e di assistenza alle persone anziane, il commercio e la ricettività legata all’andamento stagionale del turismo. Tutti settori che non eccellono in termini di salari e condizioni di lavoro.
Si è creato un circolo vizioso: i salari bassi hanno tolto la pressione alle imprese per innovare e investire in nuove tecnologie, formazione, nuovi prodotti e processi. Senza questa pressione dal lato dei costi, le imprese hanno potuto continuare a vivacchiare con modelli produttivi a basso valore aggiunto. E senza innovazione, non c’è crescita della produttività. E senza crescita della produttività, non ci sono le basi per aumentare i salari.
Strutture inadeguate: imprese, competenze e fisco
Dietro il problema della produttività si nasconde un’altra caratteristica del sistema economico italiano: l’eccessiva diffusione delle micro e piccole imprese e la loro scarsa managerializzazione. Nonostante sia ormai chiaro che sotto una certa dimensione è difficile essere competitivi, ancora molte norme disincentivano le aggregazioni o la crescita dimensionale delle aziende italiane.
Le imprese piccole hanno difficoltà a investire in ricerca e sviluppo, a formare adeguatamente i lavoratori, a implementare nuove tecnologie. Hanno anche meno potere contrattuale con i fornitori e i clienti. Il risultato è una competizione basata principalmente sul contenimento dei costi, dove il lavoro diventa la variabile di aggiustamento più facile.
C’è poi il tema delle competenze. L’Italia ha meno laureati degli altri paesi europei, gli investimenti in ricerca e sviluppo sono inferiori a quelli di tutti gli altri paesi europei e decisamente lontani dall’obiettivo del 3 per cento del PIL fissato dall’Unione europea. Il numero dei brevetti italiani è quasi la metà di quello francese e un quinto di quello tedesco.
La crisi del 2008 ha accelerato i cambiamenti strutturali già in atto legati alla globalizzazione e all’avanzamento delle nuove tecnologie. Si è determinata una polarizzazione nella domanda di lavoratori: più richiesta per quelli altamente qualificati e per quelli meno qualificati, a fronte però di una riduzione della domanda per i lavoratori con competenze intermedie. Molti dei posti di lavoro persi durante la crisi non sono stati recuperati e i nuovi posti spesso richiedono competenze diverse, in particolare digitali, che molti lavoratori non possiedono.
Secondo i dati dell’OCSE, più di un adulto su quattro in Italia non ha nemmeno le competenze base nell’elaborazione delle informazioni. E i dati più recenti mostrano che non c’è stato alcun miglioramento negli ultimi dieci anni.
Un altro elemento che pesa è il carico fiscale. Il sistema italiano pende fortemente dalla parte del lavoro dipendente e delle grandi aziende, molto meno dalla parte del lavoro autonomo e delle piccole e microimprese individuali.
A pesare ulteriormente sulle buste paga il fiscal drag, o drenaggio fiscale. Funziona così: quando l’inflazione fa aumentare i prezzi e i salari nominali crescono per cercare di compensare, le aliquote fiscali non vengono adeguate. Il risultato è che i lavoratori finiscono automaticamente in scaglioni di reddito più alti e pagano più tasse, anche se il loro potere d’acquisto reale non è aumentato. È come se lo Stato aumentasse le tasse senza dirlo esplicitamente, semplicemente lasciando che l’inflazione faccia il lavoro sporco.
Marco Leonardi e Leonzio Rizzo hanno calcolato che per un lavoratore metalmeccanico, a fronte di un aumento nominale annuale di 2.691 euro tra 2023 e 2024, ben 1.169 euro sono finiti in tasse semplicemente perché il sistema non ha tenuto conto dell’inflazione. In totale, il fiscal drag per i soli lavoratori dipendenti nel 2024 è stato tra di 17 miliardi di euro. Soldi che sono usciti dalle tasche dei lavoratori senza che nessuno ne discutesse pubblicamente.
Sindacati e contrattazione: un sistema che non tiene il passo
C’è infine una questione che riguarda direttamente chi dovrebbe tutelare i salari: i sindacati e il sistema di contrattazione collettiva. In Italia, storicamente, è alle parti sociali che è stato affidato il compito di fissare le retribuzioni attraverso la contrattazione. I contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) stabiliscono i minimi salariali e le condizioni di lavoro per ogni settore, dal metalmeccanico al commercio, dalla sanità al turismo. La politica dal dopoguerra in poi ha scelto di restarne fuori, con buone ragioni dopo l’esperienza del corporativismo fascista. Dopo quasi ottanta anni, però, questo sistema mostra diverse crepe.
Il bilancio di trent’anni suggerisce che forse sono state spese troppe energie sulle regole del mercato del lavoro, vedendo in esse l’origine di tutti i mali o lo strumento principale per lottare contro gli abusi, dimenticando o mettendo da parte i temi più strutturali. I sindacati sono stati travolti dalla trasformazione del mercato del lavoro, ma hanno anche scontato un’eccessiva tentazione di fare da supplenti alla politica, con una crescente politicizzazione delle loro strategie.
Un altro limite evidente è la difficoltà di andare oltre la protezione di chi sta già dentro il mercato del lavoro. Non è una questione di cattiva volontà, ma di struttura: gli iscritti alle organizzazioni sindacali sono prevalentemente lavoratori con contratti stabili, spesso nelle grandi aziende o nel pubblico impiego. Sono loro che pagano le quote associative, partecipano alle assemblee, votano internamente. È naturale che i sindacati tendano a tutelare in primo luogo chi rappresentano effettivamente.
Il problema è che questo lascia fuori una fetta crescente del mercato del lavoro. I giovani con contratti precari, i lavoratori delle piccole imprese, chi lavora nei nuovi settori dell’economia digitale restano ai margini della rappresentanza sindacale. Il risultato è paradossale: nonostante i giovani siano più istruiti delle generazioni precedenti, gli under 30 hanno una retribuzione oraria del 36 per cento inferiore a quella dei lavoratori over 50 e del 25 per cento inferiore a quella dei dipendenti di età compresa tra i 30 e i 49 anni. Le riforme dei contratti a termine del 2001, per esempio, hanno comportato risparmi per le imprese ma sono stati i giovani lavoratori a pagare il prezzo dell’aggiustamento.
C’è poi una contraddizione di fondo nel ruolo che i sindacati italiani hanno scelto di giocare. L’ambizione del sindacato-partito, la costante tentazione di fare da supplenti alla politica, ha rafforzato i leader sindacali ma non necessariamente le buste paga dei lavoratori. Un sindacato più attento allo scambio con la politica che a quello realizzabile all’interno delle fabbriche e degli uffici finisce per lasciare più soli i lavoratori, meno protetti di un tempo. Il risultato è che nuovi attori, come la magistratura, provano a riempire i vuoti nella politica salariale che la contrattazione storica non riesce a colmare.
In conclusione
Nel complesso, la questione salariale italiana racconta la storia di un paese che negli ultimi trent’anni ha giocato in difesa. Invece di investire in produzioni ad alto valore aggiunto, ci si è concentrati sulla difesa di tutte le produzioni, anche quelle povere e senza futuro. Invece di spingere per la crescita dimensionale e la modernizzazione delle imprese, si sono mantenute strutture frammentate. Invece di investire massicciamente in formazione e competenze, ci si è adagiati. E invece di rinnovare il sistema di contrattazione, si è continuato a difendere l’esistente.
Non ci sono soluzioni magiche per uscire da questa situazione. Servono scelte precise: favorire la crescita dimensionale delle imprese, contrastare il lavoro irregolare, investire nell’istruzione, ribilanciare il sistema fiscale e sostenere una contrattazione collettiva efficace. Per farlo serve una visione orientata al futuro che è da tempo assente dal dibattito dei principali partiti.
C’è qualche tema di cui ti piacerebbe leggere? Fammelo sapere lasciando un commento o mandandomi un messaggio. Puoi scrivermi a [email protected].


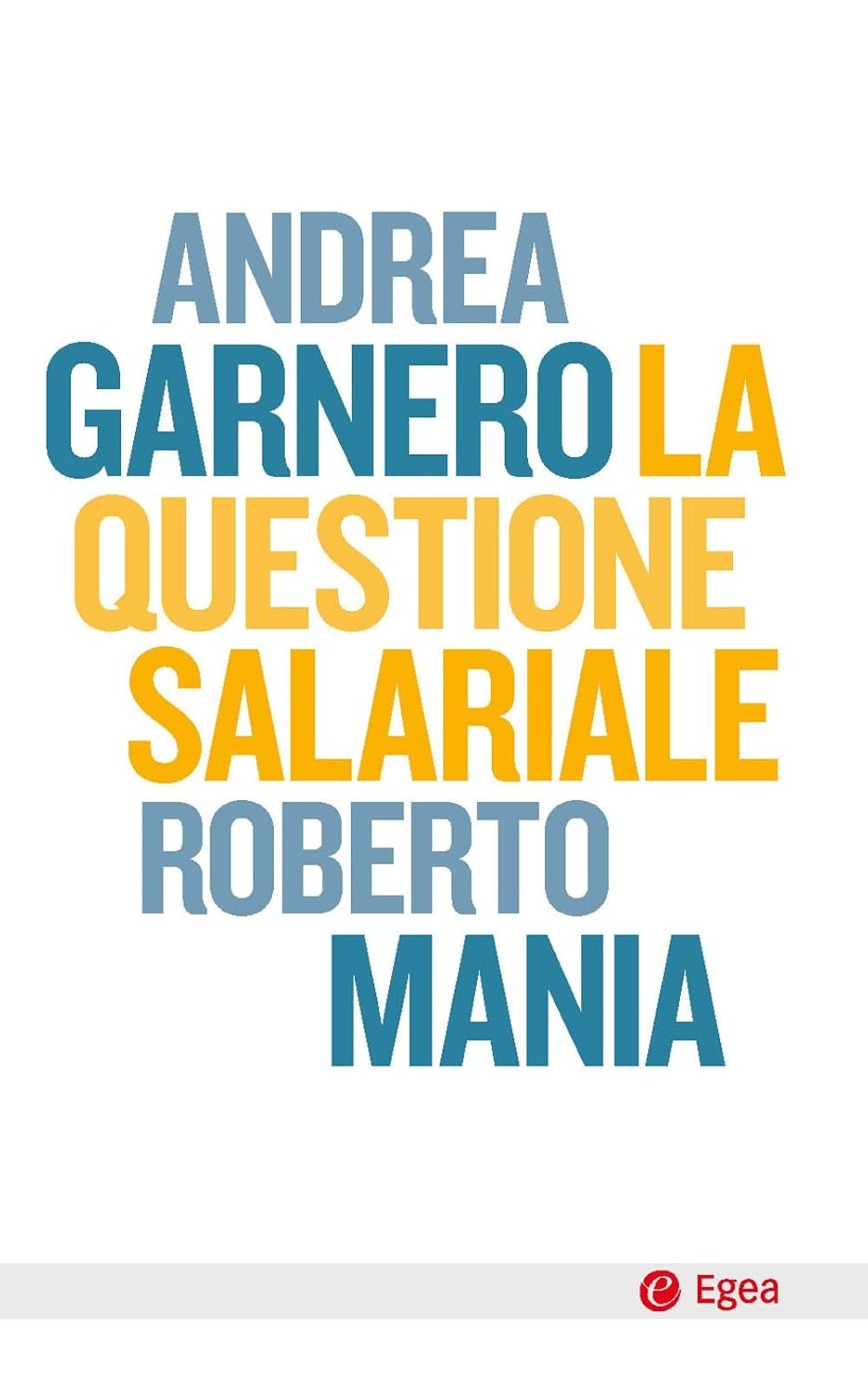

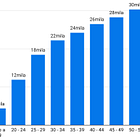
Analisi perfetta.
All'università studiamo modelli organizzativi complessi e trasformazione digitale, pensati per grandi aziende strutturate. Poi ci scontriamo con la realtà italiana delle micro-imprese, dove spesso manca la struttura per applicare questi modelli e c'è ancora una forte resistenza al cambiamento.
Credo che molti laureati vadano all’estero non solo per lo stipendio, ma perché fuori trovano contesti dove possono effettivamente applicare il metodo che hanno studiato, generando quel valore aggiunto che giustifica stipendi più alti.
E come sottolinei giustamente tu, purtroppo non ci sono bacchette magiche :(
Molto d'accordo. Aggiungerei una burocrazia inefficiente e che non ha nessuna voglia di migliorarsi. Ma anche questo si inquadra nell'immobilismo delle riforme. Chi ci ha provato (Renzi) è stato impallinato dalle lobby