Gli stipendi netti battono l’inflazione, ma solo grazie ai tagli fiscali
L’Inps fotografa cinque anni di retribuzioni: il potere d’acquisto resiste solo grazie agli sconti fiscali per i redditi medio-bassi
L’Italia ha un problema storico con gli stipendi. Da oltre vent’anni i redditi degli italiani sono sostanzialmente stagnanti, quando non in calo in termini reali a causa dell’inflazione. Le ragioni sono molte: assenza di crescita economica, bassa produttività, dimensioni ridotte delle imprese, elevata pressione fiscale e contributiva.
Ma i dati sui redditi lordi possono essere fuorvianti in quanto quello che realmente conta per le persone è quanto prendono di netto. L’Inps, nell’ultimo rapporto annuale pubblicato a fine luglio, ha analizzato l’andamento degli stipendi dei dipendenti tra il 2019 e il 2024, concentrandosi in particolare sulla differenza tra il lordo e il netto.
L’analisi considera solo i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che hanno lavorato a tempo pieno e per tutto l’anno: un campione non influenzato da variazioni nel numero di giornate retribuite.
Nel 2019, la retribuzione lorda mediana1 era di 30,8 mila euro, mentre quella media era di 36,8 mila euro. La mediana, cioè il valore centrale se si ordinano tutti i redditi dal più basso al più alto, è un indicatore più affidabile della media, perché meno influenzato da valori estremi (come chi guadagna cifre molto elevate). La retribuzione netta mediana, invece, era di 22 mila euro, pari al 71 per cento del lordo. Va ricordato che oltre alle imposte Irpef e ai contributi versati dal lavoratore, esistono anche quelli a carico del datore di lavoro (il 20 per cento), che non compaiono in busta paga ma vengono versati direttamente all’Inps.
Nel 2024 la retribuzione lorda mediana è salita a 33 mila euro, mentre quella netta ha raggiunto i 25,7 mila euro. Rispetto al 2019, il lordo è cresciuto del 7,4 per cento, ma il netto è aumentato del 16,9 per cento. Com’è possibile che il netto sia cresciuto più del lordo? Il motivo è che negli ultimi anni i governi hanno introdotto misure fiscali pensate per alleggerire il peso delle tasse sui redditi medio-bassi, in particolare la decontribuzione e i tagli all’Irpef.
La decontribuzione è stata introdotta dal governo Draghi con un primo sgravio dello 0,8 per cento per i lavoratori con un reddito lordo inferiore a 35 mila euro, aumentato poi al 2 per cento alla fine del 2022. Il governo Meloni ha ulteriormente ampliato questa misura, portando lo sconto al 3 per cento a inizio 2023 e poi fino al 7 per cento nella seconda metà dello stesso anno. A partire dal 2025, però, l’esonero è stato parzialmente rivisto per attenuarne gli effetti distorsivi una volta superate alcune soglie di reddito.
Tra il 2019 e il 2024 l’inflazione in Italia è stata pari al 16,7 per cento. Gli stipendi netti, dunque, hanno sostanzialmente mantenuto il potere d’acquisto che avevano cinque anni fa, mentre i lordi no. Questo però, come sottolinea l’Inps, è stato possibile grazie a una riduzione del prelievo fiscale finanziata dalla fiscalità generale e concentrata soprattutto sui redditi più bassi. Tra il 20 per cento dei dipendenti con i salari più bassi, il lordo è cresciuto del 7,4 per cento, mentre il netto del 14,2 per cento. Tra i redditi più alti, invece, l’aumento è stato dell’11,2 per cento sul lordo e del 12 per cento sul netto.
A questo si aggiunge un altro elemento: tra il 2019 e il 2024 è aumentato anche il numero di persone con un impiego stabile. I lavoratori a tempo pieno per tutto l’anno sono cresciuti del 6 per cento. Non solo, quindi, il reddito netto ha tenuto: ci sono anche più persone con uno stipendio continuativo.
Ma queste misure, per quanto efficaci nel breve periodo, hanno dei limiti. Prima o poi lo spazio per intervenire si esaurisce: non si possono tagliare all’infinito imposte e contributi, perché a un certo punto non ce ne sono più da ridurre senza intaccare in modo serio la sostenibilità del sistema fiscale e previdenziale. Inoltre, ogni sgravio fiscale ha un costo per la collettività, perché sottrae risorse alla fiscalità generale. Il rischio è quello di sostenere artificialmente i redditi senza affrontare il nodo strutturale: una crescita salariale sana e duratura dovrebbe basarsi su un aumento della produttività, non su interventi compensativi. Senza questo legame, gli stipendi restano deboli e la competitività dell’economia non migliora.
Se hai domande o suggerimenti fammelo sapere lasciando un commento o mandandomi un messaggio. Puoi scrivermi a [email protected].
La retribuzione annuale considerata dall’Inps corrisponde all’imponibile previdenziale visibile in busta paga o nella dichiarazione dei redditi. Include le mensilità aggiuntive ed eventuali premi, ma esclude cassa integrazione, malattia e maternità. In assenza di assenze, corrisponde di fatto alla retribuzione annua lorda (Ral). La differenza rispetto all’imponibile Irpef (usato per calcolare le imposte) è data dai contributi versati dal lavoratore.


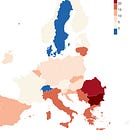
Interessante, bel lavoro. Si riesce a stimare quanto il sostegno fiscale sia stato finanziato a debito vs. redistribuendo dai redditi più alti? La crescita lorda dei salari alti è quella che ha creato lo spazio per redistribuire (fiscal drag) ma è anche quella più "sostenibile" nel lungo periodo perché evidentemente riflette dei guadagni di produttività che non sono rintracciabili altrove nella distribuzione e che non vengono dalla fiscalità generale. Ottimo anche lo stile, sempre accurato e accessibile!